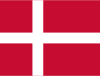Recensione: Moving Target
1995: alla metà degli anni Novanta, il metal gode di buona salute e il power più che mai. È l’anno del capolavoro “Imaginations from the other side” dei Blind Guardian, del ritorno al microfono di Kai Hansen con l’ottimo “Land of the free”; un giovane Timo Kotipelto è la nuova ugola degli Stratovarius di “Fourth dimension”, infine gl’italiani Rhapsody (non ancora con manie ignivore) componevano il loro primo demo, “Eternal glory”. Anche il versante progressive regala una buona annata di dischi memorabili, a partire dall’Ep “A change of seasons” dei Dream Theater (orfani di Kevin Moore), passando per il debutto magistrale targato Ayreon, “Carved in Stone” degli Shadow Gallery, per non dimenticare, tra i tanti, il validissimo “In your moltitude”, dei mai non troppo rimpianti Conception (“A Million Gods” resta una canzone da tramandare ai posteri). Il prog. rock vede un nuovo rigoglio nei primi passi mossi dai The Flower Kings (non più mero progetto solista di Roine Stolt), con “Back in the world of adventures”, e “The Light” degli Spock’s Beard preannuncia la grande carriera del gruppo capitanato da Neal Morse.
In Danimarca, i giovani registi Lars von Trier e Thomas Vintenberg fondano il “Dogma 95”, movimento cinematografico atto a disintossicare la settima arte dal facile “hollywoodismo” che snatura la sincerità del grande schermo. Da questo proposito imperativo nascerà, a breve, il film “Le onde del destino”, un classico dei cinefili più appassionati.
La terra di Amleto (ma anche degli Anubis Gate, Chrome Shift e Infinity Overture), tuttavia, non vive di solo cinema: qui, infatti, si è insediato da circa una decina d’anni un polistrumentista, nato a Mosca (di presunte origini nobili russo-georgiane), dalle notevoli doti virtuosistiche, amante di Mozart e Paganini. Il musicista in questione è André Andersen, classe 1961, mastermind e tastierista dei Royal Hunt, gruppo che ha all’attivo due album in studio tutt’altro che mediocri. In calce al suo profilo biografico, sul sito della band, leggiamo che l’esperienza accumulata e la sua infinita ispirazione lo rendono «a powerhouse force that drives the entire ensemble forward like a bulldozer» (una centrale elettrica che guida avanti l’intera band come un bulldozer).
Il sound dei danesi è di difficile definizione: (non) volendo semplificare, lo si può inquadrare tra un pomp-rock sui generis e il power metal più vicino all’AOR. Alcuni hanno definito il combo una versione più “aggressiva” degli Asia; Andersen cita Rick Wakeman e Jon Lord come sue principali ispirazioni, a fianco ai grandi della musica d’arte. L’Encyclopaedia metallum li definisce “melodic progressive metal”. La verità è che i Royal Hunt restano un unicum nel panorama rock e metal e proprio la natura ibrida del loro sound li configura come un gruppo dalla grande coerenza d’intenti, quanto sempre troppo sottovalutato.
Se agli inizi degli anni Novanta, “Land of broken hearts” e “Clown in the mirror” avevano già regalato emozioni, con Henrik Brockmann, interprete di alcuni buoni pezzi (“Easy rider”, “Land of Broken Hearts”, “Day in day out”, “Wasted Time”, “Legion of the Damned”), il futuro della band deve ancora scrivere pagine storiche di grande musica.
Anzitutto, la line-up del combo danese vede l’ingresso di un talentuoso cantante, proveniente dalla Pennsylvania. Donald Christopher Cooper è uno di quegli artisti che gli dei, molto probabilmente, invidiano al mondo, insieme a Michael Kiske e André Matos. Forte di una gavetta negli States e arrivato vicino a rimpiazzare il grande Rob Halford al microfono dei Judas Priest (insieme al coetaneo Ralf Scheepers), il quasi trentenne statunitense decide di unirsi al gruppo capitanato da Andersen. Si ritrova, così, catapultato, il ventisei dicembre 1994, in Giappone, durante il tour nipponico di “Clown in the mirror”. I fan del Sol levante accolgono calorosamente il nuovo cantante, che entra subito nell’alchimia della band danese e fa suo il ruolo di front-man. Nel corso della tournée, il Giappone è, altresì, devastato dal terribile terremoto di Kobe, che miete migliaia di vittime. In ricordo delle tante persone che vi hanno perso tragicamente la vita, i Royal Hunt compongono la commovente ballad “Far Away”, contenuta nell’omonimo Ep uscito nel maggio del 1995 (che include anche alcune canzoni dal vivo, tratte dal tour nipponico, e la buona strumentale barocca “Double conversation”).
Affronteremo più avanti l’analisi di questa memorabile canzone.
Torniamo ai fatti. Nel settembre dello stesso anno, esce “Moving Target”, terzo album in studio della band di Andersen, che è di nuovo produttore e autore di tutte le canzoni del platter. La copertina da “Berlino anno zero” non lascia adito a perplessità: il full-length parla, infatti, di guerre e distruzione. Lo stesso Andersen sostiene che si tratta di un concept album, volto a seguire «a man’s acknowledgment of God on a journey through time on our world which we have been building since creation» (la conferma dell’esistenza di Dio da parte di un/dell’uomo, in un viaggio lungo il tempo, nel mondo che abbiamo continuato a costruirci sin dalla Creazione). Aggiunge, inoltre, che «throughout history man has both blamed God and credited God for things that are negative and destructive, which doesn’t make sense. God does not create inquisitions, or start wars. God does not create evil, only man does» (nel corso della Storia l’uomo ha sia incolpato che ringraziato Dio per fatti negativi e distruttivi, cosa che è priva di senso; davvero Dio non crea inquisizioni o intraprende guerre. Dio non crea il male, questo lo fa solo l’uomo.) Messaggio profondo e filosofico, che dà inizio al lato “mistico” dei Royal Hunt, continuato poi sapientemente nel successivo capolavoro “Paradox”.
Se di concept album si può parlare, a rigor di termini si tratta di un concept lato sensu: il leitmotiv del disco è il tentativo dell’uomo di non incolpare Dio per la sofferenza presente del mondo, ma non c’è una storia vera e propria che abbraccia le nove tracce del platter.
Ma veniamo alla descrizione track-by track per dare un’idea di cosa ci propongono i quattro danesi.
“Last goodbye” attacca con un fade-in che vede protagonista il synth neoclassico e trascinante di Andersen. Sono pochi i tastieristi metal che possono vantare un così alto tasso di riconoscibilità dopo pochi secondi d’ascolto: vengono in mente Jens Johansson, Vitalij Kuprij, Michael Pinnella, Jordan Rudess e Derek Sherinian, una ristretta schiera di maestri dei tasti d’avorio.
La grande abilità compositiva di Andersen fa sì che, con un limitato numero di suoni (clavicembalo, oboe, organo) riesca a ottenere arpeggi, soluzioni armoniche e virtuosismi comunque memorabili. Kjaer è suo degno comprimario, ma darà il meglio di sé in “Paradox”, dove si ritaglierà più spazio per assoli da manuale. A prevalere è una sorprendente coesione tra chitarre-tastiere e la voce di D. C. Cooper, che può gestire un range vocale invidiabile, passando da caldi toni baritonali a orgastici acuti in falsetto. Il refrain è azzeccato, tra l’istrionismo di Cooper e il controcanto delle voci femminili, altro marchio di fabbrica dei Royal Hunt. I testi sono corrosivi, intrisi di ansia e depressione. “Crime is done, i’m alone in the night”: nei sei minuti del pezzo seguiamo passo passo lo sprofondare nell’io di un anonimo Raskolnikov del nostro tempo, ottuso dalla tossicodipendenza (“going’ to the needle park”) e ingabbiato in un’infanzia mai superata (“Goin’ down, you’re goin’ down like a little child”). Dopo un veloce assolo di Andersen, che sembra anticipare certe sonorità di “Holy land” degli Angra, un bel break verso il min. 5:00 ci accompagna verso il finale dell’opener, che non manca di stupire. Da un silenzio irreale si leva una preghiera recitata in modo toccante da D. C. Cooper, “Our Father, who art in heaven…” (gli svedesi Mind’s Eye, similmente, inseriranno il Padre nostro in italiano all’inizio di “Skin Crawl”, nell’album “A Gentleman’s Hurricane” del 2007).
Una brusca esplosione dà inizio al secondo brano dell’album, “1348”. Eteree voci femminili, come moire suadenti, annunciano “Future’s comin’ from the past, who’s first and who’s last”. Linee di basso traghettano, subito dopo, l’ascoltatore in un’atmosfera di roghi e re in ginocchio di fronte alla Morte nera, pandemia che sterminò un terzo della popolazione europea del Basso Medioevo. Al min. 1:15, allo scoccare del “December Forty-eight” cantato da Cooper, accordi abrasivi di chitarra rendono mimeticamente i fendenti della falce livellatrice. Alcuni minuti di grande musica strumentale preparano l’ultima strofa del brano, in un crescendo di distruzione e cadaveri ammassati. La voce di Cooper arriva su vette di puro lirismo nell’ultimo acuto del pezzo.
Attacco supponente quello di “Making a Mess”, con tanto di timpani, gong e synth di clavicembalo (che non ci risparmia gustosi tremoli barocchi). Ritmiche in puro stile metal e ancora un ritornello accattivante. Il turbinio di note vuole rappresentare la confusione mentale e il disorientamento del protagonista del brano. Si tratta di un giovane soldato cresciuto in una terra lontana (“I was raised in a faraway land”), cui vien inculcato il solo traguardo del successo a ogni costo (“tryin’ to be number one, never ever settle for less”) e finisce soldato pronto a uccidere e essere ucciso. Viene alla mente Tom Cruise nel “Nato il quattro luglio”… Il protagonista della canzone realizza, tuttavia, di star compiendo qualcosa di tragico e irredimibile sui campi di battaglia. Nel break del pezzo, l’epifania è ormai ultimata: “The wind of sadness can shade the heart of gold”. Il brano si chiude con una cadenza neoclassica, sorta di epitaffio di difficile interpretazione.
È la volta di “Far away”, uno dei cavalli di battaglia dei Royal Hunt di ieri e di oggi. La bellezza di questa breve composizione sta nella sua semplicità e nelle liriche alate, che Cooper interpreta in maniera sopraffina. Il brano trasuda sofferenza, ci sono anche synth d’organo e il tributo ai caduti di Kobe non potrebbe essere più sentito. Il ritornello è anche il vertice della bravura di Andersen nell’intendere figurativamente la musica che compone. Il tema discendente, che fa da controcanto alla voce di Cooper, rende tangibile la distanza (non solo spaziale) che ci separa dai defunti nell’aldilà e ogni cromatismo sembra un’eternità, che si aggiunge a un distacco già incolmabile. Nel finale il cantante ripete il refrain salendo di ottava in ottava, terminando con un acuto straziante che si spegne in un pianissimo da pelle d’oca: sentimento puro. In definitiva una delle miglior ballad dei Royal Hunt (che, in “Paradox”, avrà il suo corrispettivo in “Long way home” e, per quanto riguarda l’era John West, in “Season’s Change”) e, azzardo, una delle più belle ballad metal (insieme a “The spirit carries on” dei Dream Theater, “Pray” dei Gamma Ray, “I believe” degli Hammerfall, “Before the winter” degli Stratovarius e molte altre).
“Step by step” riporta il sound dei Royal Hunt su lidi meno flebili. Inizio con campanello di biciletta e suoni di traffico urbano, poi un vellicante ritmo cadenzato. Kjaer sugli scudi e subito le liriche ci riportano a temi cupi: “Switch blade dance and your friend goes down”. La canzone parla delle band di strada, in un tono tra il provocatorio e l’esortativo. Ancora una volta nel refrain torna l’idea dello sprofondare gradualmente nell’irriconoscibilità della propria dignità umana, che nega Dio e il sano rapporto con il prossimo. L’uomo interroga l’insensatezza della violenza (“somebody tell me why and what we’re fighting for”) ma non sembra trovare una risposta consolante.
“Autograph” è l’unica strumentale del platter, con un minutaggio risicato, ma comunque più significativo di quello delle brevi “Martial Arts”, “Freeway Jam” e “Third Stage”, strumentali da poco più di un minuto, presenti nei precedenti album della band. In futuro i Royal Hunt comporranno strumentali dal virtuosismo puro (pensiamo a “Fifth element”, “Memory Lane”, “SK 983”), ma è con “Autograph” che Andersen imprime la sua prima indelebile firma di maestria. Un ostinato di pianoforte, sapientemente modulato, sorregge un brano dall’incedere maestoso e poliedrico. Da ascoltare e riascoltare.
“Stay down” si mantiene sui livelli d’eccellenza dei precedenti brani. Kjaer sfodera in apertura un riff pulito da brividi, tanto semplice quanto emozionante. Suoni ottimali e tanta attitudine: basta questo per rendere memorabile l’incipit di un pezzo, che tratteggia la disillusione di un uomo alle prese con la sopravvivenza di tutti i giorni (“Are you fightin’ for survive? It’s a lousy way to live”). Si tratta, più in generale, degli emarginati della società, gli ptochoi (pitocchi/nullatenenti) biblici, che il Cristo esorta a rallegrarsi per le ricchezze che troveranno nei cieli. “Who will you run to and who will you pray to, When you’re down on the ground”: la domanda si fa ontologica.
Con “Give it up” siamo ormai sul finire dell’album. Inserti di chitarra acustica e tinte prog. introducono una strofa dall’attualità sconcertante:
Give it up just let it flow,
Killer’s runnin’ TV-show.
Razor blade in action – everything is “live”,
Scandal makes a paper “hot”,
You may like it, you may not.
Marriage, rape, divorce, somebody’s butchered wife.
Vivi e lascia vivere, non muovere un dito per cambiare il mondo; la cattiva tv, asservita al quarto potere corrotto, è lo specchio di un mondo che fa del vuoto e della violenza il suo passatempo preferito. L’ironia sagace che Andersen imprime ai testi ci pone di fronte alle scelte morali che ognuno deve compiere quotidianamente, per uscire dall’apatia e dal cinismo indifferente che caratterizza la società voyeuristica del benessere. Il brano si chiude con un crescendo dalle reminiscenze AOR.
“Time” è l’epilogo sontuoso di Moving Target e anticipa per certi versi le sonorità più coese di “Paradox”. Incipit acustico e subitanea esplosione sonora con un Cooper che sfodera un acuto terrificante. Synth di oboe dal sapore bucolico e incedere power metal (una timida doppia cassa scandisce le battute). Il tema del tempo, così filosofico e ineffabile, ha trovato e continua a trovare largo spazio in ambito metal: pensiamo agli Angra di “Time”; ai Blind Guardian di “Time what is time”; agli Helloween di “A little time”, “March of Time”; agli Stratovarius di “Father Time”; ai nostri connazionali Vision Divine (“The Killing Speed of Time”), nonché all’ultimo “The mystery of time” degli Avantasia.
Nel parlare dell’uomo, quale essere temporale, i Royal Hunt puntano tutto su un refrain da cantare a squarciagola, quando, però, nelle parole iniziali del brano è già contenuto il messaggio fondamentale: “Time, how long it’s gonna lasts? I’m livin in the past and runnin’ out of time…”.
L’uomo vive con il passato davanti a sé e il futuro alle sue spalle, un po’ come se percorresse il sentiero della vita in moonwalk.
Come bonus-track, in chiusura d’album, troviamo una versione acustica di “Far away” e nella re-release del full-length l’intero Ep omonimo.
Per tirare le somme, “Moving Target” è un disco che emoziona a ogni ascolto, pur non brillando per perfezione come il successivo “Paradox”. In realtà, sarebbe più corretto dire che i due album suddetti compongono uno dei più pregevoli dittici del metal anni Novanta. Potenziali filler come “Autograph” e “Give it up” si rivelano pezzi altrettanto validi dei precedenti, all’interno di una scaletta concisa e compatta. Niente struttura circolare delle composizioni come sarà in “Paradox”, ma poco male, “Time” chiude in modo perfetto un album memorabile.
I testi sono profondi e, nella loro immediatezza, riescono a coinvolgere l’ascoltatore e trascinarlo in ritornelli sfrenati. La frequente dissociazione tra musica (entusiasmante) e liriche (cupe) fa, altresì, riflettere su tematiche universali, intento che Andersen persegue in modo sistematico.
“Moving Target” non è un album “da sottofondo”, richiede un ascolto attento e partecipato; paradossalmente, l’ascoltatore distratto potrebbe pensare di trovarsi di fronte a un album di banale happy metal (mi riferisco a pezzi come “Making a mess”, “Step by step”, “Stay down”) e passare oltre senza troppi problemi. Pensiamo, comunque, basti la copertina del disco per togliere ogni margine di dubbio in merito.
Venendo al giudizio sulla line-up, il guitarwork di Kjaer non è mai invasivo, ma regge il confronto con il vulcanico apporto di Andersen; D. C. Cooper è da dieci e lode (anche se ad alcuni non può piacere il suo stile canoro, a tratti troppo “sguaiato” sui registri alti). La parte ritmica svolge il suo compito senza infamia e senza lode, restando poco caratterizzante: questo uno dei limiti della proposta musicale dei danesi. Gl’inserti vocali delle coriste Maria McTurk e Lise Hansen donano un tocco di ricercatezza e originalità al sound complessivo e resteranno ancora valore aggiunto dei Royal Hunt a venire.
Concludiamo con un’ultima digressione circa il prosieguo della band.
D. C. Cooper lascerà i Royal Hunt nel ’99, dopo due live-album memorabili (“Live-1996” e “Closing the chapter”), per proseguire la propria carriera solistica (il self-titled con Tore Østby esce proprio sul finire del millennio) e con altri gruppi (Silent force, Amaran’s Plight) e camei vari (Shadow Gallery, Explorer’s club, Edenbridge, Steel Seal).
La band capitanata da Andersen non si perderà d’animo e, assoldato John West degli Artension, dopo il mezzo passo falso di “Fear”, registrerà album credibili, “The mission” su tutti.
Dopo l’uscita di scena di West, sarà la volta di Mark Boals e del discusso sequel di “Paradox”. Nonostante i tanti cambi di line-up (che riguardano anche strumentisti), i Royal Hunt sopravvivranno a se stessi fino al traguardo del decimo album in studio.
È storia recente, infine, il come-back di D. C. Cooper, avvenuto nel 2011. I due album della reunion, “Show me how to live” e “A life to die for” non sono paragonabili ai capolavori anni Novanta ma i fan di Andersen & Co. (per primo il sottoscritto) non hanno saputo trattenere un empito di gioia nel riascoltare l’ugola d’oro statunitense, interprete di brani tutto sommato passabili, come “Hard rain’s coming” e “Running out of tears”.
Cosa riserverà il futuro a questa band così atipica e originale è quanto di meno scontato si possa credere: forse l’instancabile Andersen ha ancora qualche cartuccia da sparare. Nel frattempo riascoltiamo ancora una volta un classico come “Moving Target” e torniamo a riflettere sulla vita e sulla morte.
Discutine sul forum nel topic dedicato ai Royal Hunt!