Recensione: Rewind, Replay, Rebound
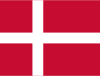
Volendo o nolendo, amandoli o odiandoli, è innegabile dire che i danesi abbiano scritto dei dischi seminali per il metal del nuovo millennio, riferendoci alle prime tre uscite discografiche, apportando alle sonorità tipicamente metal infarinate quel flavour rockabilly che dava un tocco di novità a un genere che è sempre stato aperto a contaminazioni e influenze varie. Il ritorno dei Volbeat pertanto, è senza ombra di dubbio uno degli eventi clou di quest’anno metallico ma come spesso accade l’attesa non viene ripagata appieno.
Basando la propria proposta su queste principali coordinate è considerevole e scontato che a lungo andare il rischio di ripetersi sia quantomeno dietro l’angolo; i nostri, usando l’astuzia di chi nel metallo ci naviga e assumendo in pianta stabile un certo Rob Caggiano, sono riusciti a darsi un ritocco alla carrozzeria aggiornandola, ammodernandola e mantenendo sempre l’attitudine scanzonata da bravi cowboy registrando quella piccola gemma di Outlaw Gentlemen & Shady Ladies, che presentava il combo danese in una mise più diretta e heavy sotto alcuni versi e altri, più orecchiabili e alla mano, unendo così le due facce della stessa medaglia in un connubio di pregevole fattura.
Il fascino di ricoprire posizioni da headliner e il music biz però hanno fatto breccia nei quattro rocker, così, nel 2016 Seal the Deal & Let’s Boogie invade gli scaffali dei negozi di dischi col suo sound dannatamente commerciale e scontato che fe rabbrividire la maggior parte dei fan della prima ora a causa del songwriting superficiale, scontato e di immediata assimilazione, favorendo soluzioni più dirette alle composizioni più personali alle quali ci avevano abituato in questi anni.
Il detto dice che dopo aver toccato il fondo si può solo risalire; i nostri però non vogliono seguire le regole e allora decidono di scavare ancora più giù, non per cercare il petrolio sia ben chiaro, ma per vedere quanto si riesce a diventare patetici scrivendo un’ora di musica seppur piacevolmente orecchiabile, banale ed elementare.
I Volbeat ci sono riusciti e vincono questo grottesco contest a mani basse.
Cosa si è rotto nella macchina Volbeat? Probabilmente nulla, ma sono loro che stanno inziando a rompere e a stancare con le loro composizioni prevedibili e adolescenziali.
Dove sono finiti i riff, il groove che aveva fatto la fortuna della band nella seconda metà degli anni 2000? Forse chiuso in un cassetto, a chiave, e la chiave è andata persa. Ma è tutto così drammatico? No, non tutto, ma andiamo per gradi descrivendo quello che rappresenta il sesto studio album dei rocker di Copenhagen.
Essere o non essere? NON ESSERE.
Rewind, Replay, Rebound non è un album metal, neppure alla lontana; possiamo definirlo un disco di rock radiofonico dove, a parte qualche sprazzo di classe, cosa innegabilmente comune tra questi musicisti, si standardizza su un songwriting prevedibile come la vittoria dello scudetto della Juventus con suoni piatti e artificiali, ma ciò che balza di più all’orecchio è la scarsità di idee che la band ha espresso per tutta la durata del disco.
Se qualche segnale allarmante era già stato dato dalla prima manciata di singoli estratti e pubblicati dalla band, il peggio arriva mettendo il disco sul lettore, e dopo vari ascolti si fatica a credere che sia effettivamente un lavoro dei Volbeat se non fosse per la voce di Michael Poulsen, come sempre autore di una prova sopra le righe, vocalist dotato di una timbrica molto personale e che migliora disco dopo disco.
Il platter effettivamente gira tutto intorno al suo uomo di punta con la sua voce che sovrasta letteralmente il resto degli strumenti, sottolineando una batteria che in alcuni momenti è addirittura impercettibile tanto suona bassa, fiacca e sintetica mentre le chitarre hanno una distorsione più consona a un disco dei R.E.M. che a uno di qualunque altra band metal/hard rock.
Fossero questi i problemi si potrebbe pure soprassedere, ma appena si schiaccia play il disco viene aperto da una delle opener più fiacche della storia del metal/rock. Solitamente l’apripista, al netto delle intro, è un brano trascinante, non necessariamente veloce ma comunque trascinante. L’unica cosa che Last Day Under the Sun trascina è la sua durata per quasi cinque minuti di noia con delle chitarre che sembrano uscite da una B-Side di Brian Adams e un ritornello più consono a una sigla di una pubblicità di creme solari.
Il problema più grosso, tuttavia, si raggiunge quando la band tira fuori gli artigli e, invece di graffiare, lo fa per farsi fare la manicure; Pelvis On Fire è carina ma è palesemente la brutta copia di Sad Man’s Tongue, Die To Live un rockeggiante episodio con tanto di pianoforte e sax dove spicca l’ormai classico duetto che la band sta proponendo album dopo album ma in questo caso onestamente da dimenticare. The Everlasting, probabilmente appartenente alle sessioni di registrazione del precedente mediocre platter, non fa paura a nessuno e ribadisce il concetto di una maglietta lavata e sbiadita, che ha perso colore, smalto o quel che si vuole, ma non punge. Simpatiche composizioni identiche ad altre già presenti nei precedenti lavori ma più scontate.
La cosa che ci ha lasciato perplessi, oltre ai suoni che rasentano l’imbarazzante per quanto morbidi e privi di mordente, sono le linee vocali, sempre molto belle e valorizzate dalla solita prova eccelsa di Poulsen ma risultano, oltre eccessivamente filtrate, un collage di pezzi di altre songs appartenenti alla discografia della band. Le buone idee fanno capolino in episodi come l’oscura Sorry Sack Of Bones, che sembra riprendere il tema della sigla storica del telefilm Batman, oppure nella scanzonata ma al contempo più “heavy” Cheapside Sloggers dove il bel guitar solo è firmato dall’illustre ospite Gary Holt , il tutto nuovamente smorzato da una produzione mai all’altezza che predilige le patinature e i fiocchetti rosa a discapito dell’impatto e della dinamica.
Gli episodi carini non mancano come le sopraccitate due song, la ballad When We Were Kids che è abbellita da un ritornello arioso e un break centrale che ricorda tanto quello di Perfect Stranger dei Deep Purple, oppure le piacevoli e basilarmente easy listening Rewind The Exit, Cloud 9 così come la morbida e zuccherosa Maybe I Believe, fanno il loro dovere ma si tratta solo ed esclusivamente di canzonette carine, nulla più e nulla meno, che negli anni precedenti sarebbero state ultilizzate al massimo come bonus tracks oppure B-Sides in qualche singolo.
Un’altra domanda che ci siamo posti è il perché dover inserire voci femminili in praticamente tutte le canzoni con alcuni casi eclatanti dove le stesse nei ritornelli addirittura vanno a coprire la bella voce dell’imponente singer rendendo la proposta ancora più dozzinale e banale di quello che sarebbe stata altrimenti.
La band è composta da quattro musicisti con le palle quadrate e ci si chiede il perché abbiano scritto un album così poco ispirato e indirizzato esclusivamente alle radio che sarebbe più consono a una band rockabilly che ambisce a riempire i pub di provincia e non le arene dei futuri festival in giro per il mondo.
Non bastano una manciata di song che funzionerebbero alla grande come colonna sonora al ballo “Incanto sotto il mare” con un George McFly pronto ad affondare il colpo con la bella Lorraine; il resto si lascia pure ascoltare senza troppo impegno tra una faccenda domestica e l’altra oppure mentre con la nostra bella auto utilitaria andiamo in spiaggia, ma siamo anni luce rispetto alle prime composizioni così come da quello che fu il criticatissimo Outlaw Gentlemen & Shady Ladies lasciandoci oltre che l’amaro in bocca seri dubbi sul futuro metallico di questa band.
Spesso quando le idee finiscono è giusto fermarsi e ricaricare le batterie invece che minare la propria credibilità con un disco privo di personalità, mordente e che ogni singolo brano, potenziale hit da radio, suona come la brutta copia di un qualsiasi brano scritto dalla stessa band anni prima.
Purtroppo abbiamo a che fare con una bocciatura, che senza i pochi spunti interessanti e l’ottima prova del buon Michael Poulsen sarebbe stata ancora più pesante. Di sicuro la band si starà fregando le mani e riempendo le tasche, così come la Universal canterà vittoria per aver creato una nuova macchina ammazza classifiche che un tempo però fu un carro armato di groove.



