Recensione: Systematic Chaos

Dream Theater, ancora loro. Dall’inizio del nuovo millennio a oggi il loro nome è stato associato a un numero abnorme di uscite, fra album da studio, live, progetti solisti e collaborazioni esterne. A “Octavarium” era toccato tracciare l’ultimo tratto del cerchio, chiudere definitivamente il capitolo Atlantic Records, segnare la fine di un’era, di lì a breve immortalata nel monumentale “Score”. Oggi spetta a “Systematic Chaos” fissare un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza, completamente slegato dai precedenti lavori. Qualcosa di nuovo e del tutto diverso. Se non altro, in linea di principio.
In effetti, alla vigilia della sua uscita non era ben chiaro che cosa attendersi dal nuovo Dream Theater. Uno sguardo al recente passato non avrebbe fatto che confondere maggiormente le idee. Dopo Six Degrees, Train of Thought. Dopo Train of Thought, Octavarium. Tre album che si direbbero quasi scritti da tre band diverse. A riprova del fatto che al teatro dei sogni piace cambiare rappresentazione ogni notte. O almeno, così è stato fino a oggi.
Panem et circenses. Ecco qui in due parole “Systematic Chaos”. La sintesi in ottanta minuti fitti e densi di tutto ciò che i Dream Theater hanno rappresentato in un ventennio di carriera. Nel bene e nel male. Ci sono i Dream Theater intraprendenti e spericolati dei primi anni ‘90, maestri nel rievocare l’anima del progressive dei padri per infondere nuova vita in un corpo di lucente metallo. Ci sono i Dream Theater ultratecnici e ultramoderni, quelli sfrontati a sufficienza da schiaffeggiare i vecchi estimatori con brani duri, freddi e involuti all’esasperazione. Ci sono anche i Dream Theater sornioni e un po’ ruffiani che tra una suite e l’altra accettano di barattare qualche bizzarria ritmica per una libbra abbondante di melodia, da reinvestire subito in un singolone strappaconsensi. Tutte le molteplici forme assunte dalla band nei vari stadi della sua evoluzione sono qui presenti al gran completo. Dov’è il problema? Che quell’evoluzione sembra essersi interrotta.
Let the music do the talking
Ci sarà tempo per approfondire questo punto. Si sospenda dunque la disamina: è il momento di schiacciare il tasto play e lasciare la parola alla band. Accantoniamo per il momento l’iniziale “In the Presence of Enemy part I”: nei live sarà suonata come un tutt’uno insieme al suo seguito, e insieme al suo seguito la esamineremo in questa sede. Prendiamo dunque le mosse dal secondo brano. Il più breve, il più facile, il più orecchiabile. “Forsaken” vi si pianterà in testa fin dal primo ascolto, su questo non ci piove. Dal primo all’ultimo istante è la melodia a spadroneggiare liberamente, imponendosi sulle linee vocali di un impeccabile Labrie e sul lavoro di fino di un Rudess insolitamente controllato. L’immediatezza di un refrain caldo e sentimentale pare destinata a far breccia nei cuori del grande pubblico, ma non sa sfuggire a una certa monotonia di fondo che finirà immancabilmente per attirarle il dispregio degli afecionados del progressive. Quello che tutti saranno però fin da ora costretti ad apprezzare, volenti o nolenti, è l’impegno alle sei corde di Petrucci. Se in “Octavarium” i riflettori erano tutti per il redivivo James, questa volta al centro del palcoscenico ci finiscono di diritto le chitarre di John. Lasciamo stare il solito, noiosissimo discorso tecnico: qui si parla di ispirazione. Ogni riff, ogni assolo, ogni singolo tocco è esattamente là dove dovrebbe essere, così come dovrebbe essere. Perfino su “Constant Motion”. Per chi scrive, il punto più basso dell’album, una caduta di stile che poteva e doveva essere evitata. E non tanto – meglio: non solo – per la modesta qualità del songwriting. Certo, Labrie canta una delle strofe più squallide della sua carriera (e Portnoy non aiuta), le tasitere sembrano ficcate nella composizione quasi a forza, il livello compositivo precipita a più riprese in picchiata verticale verso le fredde gole della mediocrità. Qualcosa si salva: il ritornello non è il peggio e gli scambi mediani tra basso e chitarra aiutano il pezzo a tenersi a galla. Ma davvero, dopo “Train of Thougth”, c’era bisogno di omaggiare di nuovo in modo tanto spudorato i buoni vecchi (a dire il vero ormai più vecchi che buoni) ‘Tallica?
In attesa che i ragazzi di New York riflettano su questo punto, apriamo le porte a “The Dark Eternal Night”. Dirla controversa è poco. L’incipit è persino avvilente: tra la posticcia cattiveria dell’apertura strumentale, la banalità di una strofa che più scontata non si può e l'(ab)uso di agghiaccianti filtri vocali – Portnoy ricordati che non sei un cantante – sembra che ogni speranza di riscatto sia destinata a essere risucchiata nell’oscuro sifone del più sordido nu metal. Possibile che la tirino di lungo per quasi nove minuti? No, grazie al cielo no. Il refrain offre uno spiraglio di luce, il successivo break strumentale disperde definitivamente ogni nube. Minuto 3:33: si aprono le ostilità. Inizia Rudess a fil di spada, Petrucci gli va dietro con la clava, sostenuto dallo scudiero Myung. Portnoy controlla tutto dall’alto, con un occhio fisso al cronometro. Nella mischia ci finisce di tutto, dagli improvvisi blast-beat agli estemporanei cenni vaudeville. Bastonate, petali di rosa e di nuovo bastonate. Quando il prepotente ritorno del riff principale pone fine al conflitto, si rimane quasi interedetti: è stato tutto un sogno? Sono davvero i Dream Theater?
Sì sì, sono loro. Come sono loro quelli di “Repentance”. I Dream Theater, non i Pink Floyd o i Porcupine Tree – sebbene lo stesso Steve Wilson sia uno dei tanti ospiti a prestar la propria voce sul brano. Se non l’avete già fatto, sottovaluterete questa canzone. Troppo pacata, troppo lenta, troppo onirica perché possiate apprezzare subito tutti e undici i minuti in cui si dilata. Prendetevi dunque un po’ di tempo, e dedicatele qualche ascolto in più. Già che ci siete, riascoltatevi anche “The Glass Prison”, “This Dying Soul” e “The Root of All Evil”, perché quello che avete innanzi è il quarto capitolo di una saga iniziata nell’ormai lontano 2002 (è davvero passato così tanto tempo?) e ancora ben lungi dal giungere all’ultimo passo. Questa volta, lo avrete capito, niente assalto frontale. Solo una nenia soffusa, onirica, a tratti persino ipnotica, che tanto deve alla tradizione psichedelica. Sì, ci vorrà un po’ di pazienza per apprezzarla come merita.
Basteranno invece un paio di ascolti per innamorarvi di “Prophets of War”. Oppure per odiarla, a vostra discrezione. Un tempestivo esame del DNA non potrà che attribuire la paternità dei songwriting a quei Muse la cui ombra già si stagliava alle spalle delle varie “Panic Attack” e “Never Enough”. Ma, diamine, se non è una canzone coinvolgente questa! Labrie si traveste da Bellamy ed entra in diretta competizione con l’originale, sfoderando un falsetto da brividi. Le tastiere fanno sentire il proprio fiato elettrico sulle strofe e su un refrain maiuscolo, Petrucci rinuncia all’assolo per far spazio ai cori dei fan appositamente convocati per l’occasione. La speriementazione può attendere, l’impatto avviene tutto sul piano emotivo. Non so voi, ma questa dal vivo non me la voglio proprio perdere.
Ora però legatevi all’albero maestro della nave, e ordinate ai vostri compagni di non slegarvi a nessun costo, avvenga ciò che avvenga. Ci stiamo avvicinando al finale, al lido delle sirene. E qui, finalmente, possiamo liberarci della preoccupazioni mondane e abbandonarci alle note d’ambrosia dei più fini cantori olimpici. Tocca a loro trasformare quello che finora era stato un disco come tanti in un disco da Dream Theater. “Ma come? Sono solo un paio di brani…”. Vero, giusto, sacrosanto. Ma se darete un’occhiata al minutaggio, vi accorgerete che questo paio di brani da solo riempie metà disco. Il che, davvero, non è poco.
Ripartiamo dunque con “The Ministry of Lost Souls”. Per chi scrive, l’apogeo dell’album. Punto. Poi, potete definirla una ballad (un quarto d’ora di ballad?) di gusto sinfonico, una suite di ascendenza – ancora una volta – pinkfloydiana, una nuova “Octavarium” in minatura (le somiglianze non sono poche). Potete descriverla in questi e mille altri modi, come vi pare. Io mi contento di sentire i brividi sotto la pelle ogni volta che passa nello stereo, e ascoltarla e riascoltarla fino a che non mi sanguinano le orecchie. Perché in un modo o nell’altro, tra diecimila imitatori che ormai potrebbero anche averli superati dal punto di vista tecnico, questi cinque sanno sempre dare qualche emozione in più.
E se ancora non ne siete convinti, è il momento di passare all’ultima suite, “In the Presence of Enemies”. Pronti, via: l’overture è tutta strumentale, con un Petrucci mastodontico a fare la parte del leone. Afferratevi a qualcosa di saldo o sarete trascinati via dai vorticosi intrecci chitarre/tastiere, che soltanto il canto orfico delle sei corde in assolo sa chetare. I minuti scivolano via come sabbia tra le dita, poi finalmente entra in scena l’anfitrione Labrie a spezzare in mille frammenti la continuità di un riffing camaleontico, profondo e incisivo. Si agganciano le tastiere e parte il crescendo – pochi attimi e la voce si stacca per lanciare gli strumenti solitari alla ricerca dell’apoteosi finale. Ma è ancora troppo presto, e il silenzio inghiotte ogni cosa. La rinascita è lenta e laboriosa: poco alla volta un guardingo Labrie risveglia i compagni assopiti, riscuotendoli dal sonno in un refrain inquieto e maligno. È un concitato certame in cui la luce della strofa si scontra con le tenebre del chorus, prolungando le ostilità nei passaggi successivi. Giorno e notte si avvicendano ancora e ancora nell’arco di pochi minuti, i ritmi si fanno sempre più incalzanti, la tensione cresce, di nuovo il climax parte e di nuovo si interrompe, anche se questa volta solo per un attimo. Troppo è l’adrenalina accumulata, e la danza degli strumenti non può che ricominciare all’istante, frenetica, caotica, scalmanata. Poi, finalmente, il trionfale ritorno del tema principe separa i contendenti e ripristina l’ordine. Un nuovo breve crescendo, più sereno, che questa volta riesce a sfogarsi sull’ultima liberatoria ripetizione del refrain. L’ombra si dirada, poi è silenzio. E, diciamolo pure, capolavoro.
Panem et circenses
In effetti, in un modo o nell’altro questi ragazzi di capolavori sono sempre riusciti a infilarne almeno uno persino nell’album più deludente. Anche nei momenti di maggiore difficoltà, se la sono sempre saputa cavare, sia pure per il rotto della cuffia. Tuttavia non ci si può certo contentare di prendere il buono e dimenticare il cattivo. E se gli ultimi due tiri della giornata sono stati centri pressoché perfetti, bisogna mettere a referto anche una traccia e mezzo del tutto fuori bersaglio. Da questo punto di vista, come già anticipato, cruciale si rivela l’incidenza dei singoli brani rispetto alla durata complessiva dell’album: basterebbe una “In The Presence of Enemies” da sola a contrastare quattro o cinque “Constant Motion”. I problemi non stanno certo qui. E neanche sulle prove dei singoli si può certo trovare qualcosa da recriminare: di Petrucci si è detto abbastanza, Labrie sta vivendo una seconda giovinezza e si sapeva, Myung è la solita inossidabile certezza e Portnoy offre l’ennesima conferma di tutta la propria tracotante esuberanza (certo che se pensasse di meno al microfono e di più alla batteria sarebbe meglio per tutti). Qualche parola in più va obbligatoriamente spesa per Rudess. Se in “Octavarium” aveva avuto modo di togliersi parecchie soddisfazioni, monopolizzando persino l’introduzione della title-track, questa volta il suo ruolo si fa più complesso. In fase di assolo il suo contributo è relativamente contenuto, e sui brani più tirati (i meno riusciti) la sua presenza si fa persino accessoria. Tuttavia nei momenti cruciali Jordan non tradisce: decisivo, anche se forse non troppo evidente, è il suo apporto su tutte le tracce più ispirate, non ultima la suite finale, soprattutto nell’ambito dei molti duelli intrapresi con le chitarre. Un lavoro senza dubbio più oscuro del solito, ma di grande puntualità e tempismo, come solo ai grandi riesce. No, non sta certo nelle individualità il problema.
Il limite – l’autentico limite – di quest’album è altrove. Lo avevamo già detto: ‘panem et circenses’. Quello che il popolo vuole, al popolo sarà dato. E un atteggiamento del genere sorprende un po’, se a tenerlo sono i Dream Theater. Gente che fino all’altro ieri aveva offerto ampia dimostrazione di fregarsene bellamente di quel che il popolo pensava o chiedeva. Invece che proseguire oltre, invece che scalare un nuovo gradino, questa volta si sono fermati, come a fissare la propria posizione, quasi a dire “ecco, questi siamo noi, oggi”. Per tale ragione “Systematic Chaos” avrà qualche cosa di buono da offrire a ogni ascoltatore, o quasi. Quanti in maggiore o minor misura abbiano apprezzato un qualsiasi capitolo della storia dei Dream Theater, troveranno quivi un aggancio, un richiamo più o meno esplicito a ciò che hanno amato. Alcuni brani potranno riconciliare i fan delusi dagli ultimi lavori, altri non faranno che acuire la loro acredine. Difficilmente un album del genere potrà essere apprezzato interamente, dalla prima all’ultima nota. Tale è d’altronde il prezzo da pagare quando si cerca di venire incontro ai desideri di tutti.
Se sia un prezzo troppo salato, sta ai singoli stabilirlo. Il più grosso rammarico di chi scrive sta nella pressoché totale mancanza di novità in un disco che avrebbe dovuto rappresentare l’alba di una nuova era. E non si intende certo puntare il dito contro le mille citazioni autoreferenziali (chiamateli pure autoplagi o come vi pare) che si trovano disseminate in quasi tutte le composizioni – ormai fanno parte del loro modus componendi, che vi piaccia o no. Più semplicemente, questi sono i Dream Theater, i soliti Dream Theater che tutti conoscono, e la trama del film è già nota in partenza. D’altra parte, c’è anche da dire che quando si parla di feeling in fronte a certe composizioni bisogna levarsi tanto di cappello, e gli ultimi quaranta minuti da soli ne recano eloquente testimonianza. Per stavolta, dunque, può andar bene così. La speranza però è che ora i ragazzi si prendano un po’ di tempo per riflettere e ricaricare le batterie: gli ultimi anni li hanno messi sotto torchio a ritmi massacranti – sia pure più o meno volontari – e gli autentici capolavori hanno bisogno di tempo per maturare. Classe ed esperienza sono finora bastati a tenerli a galla anche nei momenti più difficili: del resto non sono in molti a potersi permettere un album come questo nella propria discografia. Con un altro nome in copertina, insomma, probabilmente saremmo qui a leccarci i baffi e ringraziare per il lauto pasto. Eppure, chissà perché, quando si parla dei Dream Theater non si pretende nulla di meno della luna. Forse in futuro la luna arriverà – in fondo è già arrivata una volta, nell’ormai lontano 1992. Nell’attesa, non ci resta che goderci in silenzio i suoi variopinti riflessi, tenui schizzi di luce sulla superficie increspata di questo “Systematic Chaos”.
Riccardo Angelini
Tracklist:
1. In The Presence of Enemies Pt.1 (9:00)
2. Forsaken (5:36)
3. Constant Motion (6:55)
4. The Dark Eternal Night (8:51)
5. Repentance (10:43)
6. Prophets of War (6:01)
7. The Ministry of Lost Souls (14:57)
8. In The Presence of Enemies Pt.2 (16:38)


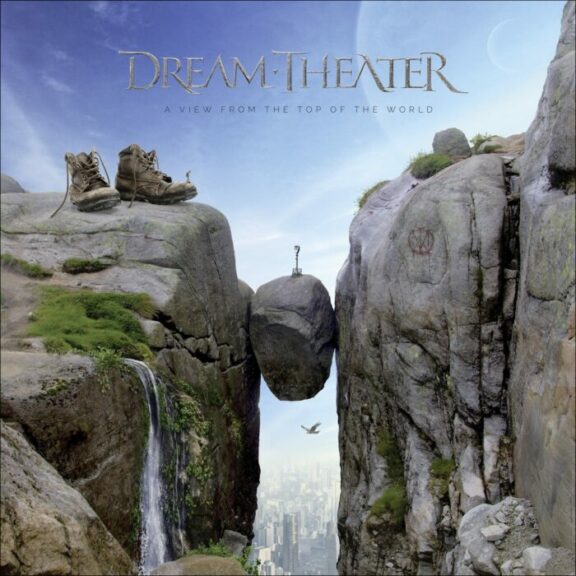
![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)


![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)
![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)

