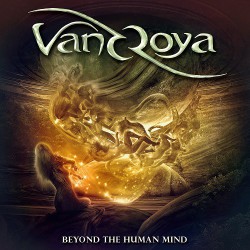Recensione: Beyond the Human Mind
Nati nel 2001 come giovane e promettente band di ragazzi dediti a suonare qualche cover, i brasiliani Vandroya procedono senza fretta, con un EP dal titolo “Within Shadows” rilasciato nel 2005, ed otto anni dopo finalmente fuori con il primo full-leght: “One” (2013). Un disco estremamente piacevole, il debut, che presentava la band come un convincente connubio tra le ritmiche ed il mood carioca degli Angra, linee melodiche ed atmosfere stile Kamelot e venature progressive alla Symphony X; forti anche della voce in primo piano di Daísa Munhoz, bella e talentuosa cantante che alterna linee più rockettare ad altre più sensuali, senza mai sfociare nell’operistico. A quattro anni di distanza, eccoli tornare sul mercato per la scuderia della svedese Inner Wound Recordings con “Beyond the Human Mind”: finalmente un titolo complesso (e dire che per pensare il precedente hanno avuto dodici anni!); artwork ad opera dell’ormai istituzionale Felipe Machado Franco.
I ragazzi cercano di bissare il successo del debut, che si ergeva su un singolone come “Why should we say Goodbye” (200.000 visualizzazioni su Youtube, non male per una band esordiente), peraltro con un plagio abbastanza evidente a “The Seven Angels” degli Avantasia nel ritornello.
Lanciato “Beyond the Human Mind” nel player, ciò che appare chiaro già dai virtuosismi in sweep picking in apertura, è la voglia della band di stupire. L’attacco in doppia cassa e tastiere del singolo “The Path To The Endless Fall” sono di quelli giusti da togliere il fiato agli amici powerelli vissuti a pane e Angra, così come la bella linea di basso e la cavalcata in crescendo della strofa che sfocia in un prevedibile ritornello melodico. Subito bravissima la trascinante Daísa nell’impostazione e nell’interpretazione molto personale. Un po’ più contemporanea nello stile la successiva “Maya”, di nuovo con una bella linea di basso ad opera di Giovanni Perlati nella strofa, riff tirato e di nuovo ritornello melodico su tappeto di tastiere. Anche con la successiva “Time After Time” sembra che la band continui a correre senza mai fermarsi salvo per i soliti ritornelli catchy, mentre repentini cambi di tempo ed arrangiamenti tipicamente carioca la fanno da padrona.
Ci vuole la ballad “Last Breath” per far uscire il lato più ruffiano ed AOR della band… e quanto dico ruffiano intendo che un pezzo del genere potrebbe tranquillamente entrare nella discografia di Shakira – coi suoi “baby” provocanti, l’arpeggio di chitarra, quel vibrato sensuale, quasi un gemito, su “smile”, il solo pulito e le atmosfere calde e distese – il che non è necessarimaente un male, chi scrive è un grande fan della cantante colombiana.
Altro singolo per la band, “I’m Alive” ricomincia a pestare duro, illudendo in apertura con un riff tipicamente hard rock che fa solo da preludio al solito pezzo power tirato col ritornello melodico voce su trapano elettr… ehr… doppia cassa. Nessun sussulto neppure con la successiva “You’ll Know My Name”, se non per un bizzarro clavicembalo nella strofa, il ritornello arioso ed un inspiegabile effetto sirena della polizia che se lo senti mentre guidi… io ti ho avvertito.
Seconda ballad di “Beyond the Human Mind”, sempre a rimarcare l’anima romantica e latina dei Vandroya, stavolta si parte voce e pianoforte, con chitarre, basso e batteria che entrano solo in un secondo momento: “If I Forgive Myself”, di nuovo a rimarcare il talento di una sempre più ammiccante Munhoz. Forse sei minuti e quaranta sono troppi, però, anche per il più romantico degli ascoltatori.
Chiusura per la suite, la titletrack progressive “Beyond the Human Mind”: con un titolo così pretenzioso non poteva certo uscire come un brano da tre minuti netti. Qui a mancare è proprio il ritornello, un po’ anonimo che si perde in un uragano di soluzioni tecniche che vanno dal canonico duello tra chitarra e tastiera a momenti più d’atmosfera. Al termine del giro sulla giostra si rimane un po’ frastornati, forse appesantiti da un ascolto che sulla carta sembrava dovesse risultare piuttosto agevole.
“Beyond the Human Mind” è un disco che può vantare un’ottima produzione, un buon songwriting, straordinarie capacità esecutive ed una prova superlativa della Munhoz; un’impetuosa ventata d’aria calda dall’America Latina. Peccato che al netto dei cinquantatré minuti del lavoro manchi una vera e propria hit, un pezzo di quelli che fanno schizzare le visualizzazioni su Youtube come la già citata “Why should we say Goodbye”.
Da un punto di vista meramente musicale, per superarsi i ragazzi hanno indubbiamente bisogno di mettere meglio a fuoco l’obiettivo: da un lato si ha l’impressione che la band ambisca a fare del power con importanti contaminazioni progressive, spingendo su interessanti soluzioni strumentali, dall’altro la voce caliente e sensuale di Daísa li trascina verso uno stile più melodico e commerciale. Queste due anime sembrano giungere solo raramente ad una sintesi del tutto chiara e completamente convincente, lasciando trasparire in molti passaggi un mero e sterile esercizio di doti tecniche, dalla voce alle parti strumentali. Le qualità dei musicisti sono fuor di dubbio, ma dai brasiliani Vandroya attendiamo il guizzo di personalità, la capacità di fondere differenti orizzonti attraverso un’unica, esotica prospettiva.
Luca “Montsteen” Montini