Recensione: Denial

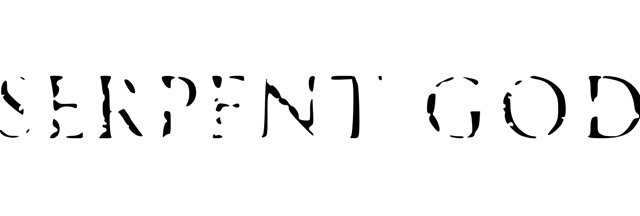
Formatisi soltanto due anni fa, i Serpent God non si sono persi d’animo e ha dato (quasi) subito alle stampe il loro debut-album, “Denial“.
Provenienti dalle feconde terre di Finlandia, i tre guerrieri tentano l’attacco all’underground metallico con un disco che, come sempre, rivela di primo acchito l’enorme preparazione tecnico/artistica dei musicisti provenienti dal circolo polare artico. Underground? Sì, poiché, al contrario di tanti colleghi che praticano l’AOR oppure l’hard rock, l’intenzione dei Nostri non è quella di scalare le classifiche ma quella, al contrario, di scendere le scale che portano ai più reconditi anfratti dell’animo umano.
Il mezzo? Il doom. O, meglio, una miscela riuscita di death, doom e, soprattutto, post-doom. Un termine relativamente nuovo, quest’ultimo, adatto a certificare uno stile che si toglie la polvere dalle spalle per dar vita a qualcosa di moderno, che abbia cioè un flavour adatto ai tempi che cambiano tanto velocemente quanto vorticosamente.
Orbene, detto questo, non è che il terzetto finlandese declini così tanto dai dettami natii del doom per scivolare in qualcosa di estraneo alla cultura del metallo. Niente affatto. Il growling roco, cattivo, intriso di sangue, a tratti disperato di Samu Männikkö non lascia spazio a dubbi interpretativi: spunti evoluzionistici a parte, quello che percepisce l’orecchio è strettamente legato al genere che, ancora oggi, nella sua emanazione più ortodossa, regala fior di emozioni agli appassionati degli slow-tempo e non solo (“Keyhole“).
Quel che cambia è invece l’approccio alla foggia musicale di cui si tratta. Un avvicinamento che porta con sé una buona dose di melodia, come dimostra la struggente “Beneath“, intrisa di passione, di malinconia, di un ribollire di morbide emozioni che non possono che portare ai singulti della shoegaze. E qui il cerchio si chiude, alla maniera del black, insomma, giacché l’incrocio del doom con quest’ultima porta a un rilassamento generale del sound, dirigendolo verso una direzione più votata all’introspezione che all’esternazione. Relegando altrove l’aggressività e la potenza, in taluni casi esacerbate dalla voglia di rilasciare nell’etere sensazioni estreme, terremotanti. Con la sola, unica eccezione di una schiaffeggiata di blast-beats in “Oblivion” (sic!). Eccezione che, come si suol dire, conferma la regola.
E così le nove canzoni del disco, rigorosamente intitolate con una parola sola, scivolano come foglie secche, autunnali, sulla superficie dei meravigliosi, solitari e placidi specchi d’acqua della Terra dei Mille Laghi. Il songwriting, oltre a essere formalmente corretto per la bisogna, è di classe, per cui ogni singolo episodio fa storia a sé, pur essendo immerso nella matrice che forma la base dell’LP.
Come ci si poteva aspettare da quanto più sopra riportato, il sound è certamente ricco di energia (“Sermon“) ma non si propone come un qualcosa di massiccio, di possente. Al contrario, sembra quasi che si cerchi la fuga dall’obbligo di erogare rilevatissime quantità di watt per lasciar cantare la chitarra di Männikkö (“Revelation“), in tal modo libera dall’occuparsi di parti ritmiche estenuanti. Allora, così facendo, le song vengono ammantate dai riflessi delicati ma fulgenti delle distese liquide le cui onde, quasi, s’accordano con quelle sonore; per una sensazione davvero piacevole di rilassatezza, preambolo alla meditazione e alla riflessione. Rese intense con il tocco lisergico di “Void“, quasi quest’ultima traccia sia l’anello di congiunzione con il doom classico.
Inoltre, l’apporto delle tastiere, a parere di chi scrive assolutamente imprescindibili in tali casi, unitamente a qualche raro accenno ambient, non fanno altro che aggiungere sale alla pietanza che, alla fine, si rivela completa e gustosa in tutti i suoi aspetti. La quale, metaforicamente, potrà soddisfare parecchi palati. “Denial“, pertanto, pur essendo un’Opera Prima, ha tutte le carte in tavola per rendere Serpent God fra i migliori interpreti del doom moderno. Anzi, del post-doom.
Daniele “dani66” D’Adamo

