Recensione: Octavarium
Octavarium: l’ottava fatica di una delle prog metal band più blasonate del panorama mondiale è finalmente gettata in pasto al pubblico famelico e affamato. Mai prima d’ora i Dream Theater si sono trovati a un passo sì cruciale della loro carriera. Mai prima del controverso Train of Thought perfino i fan più accaniti si erano scoperti in imbarazzo davanti a un album scarsamente ispirato e fin troppo derivativo. Pochi erano riusciti a farselo piacere, e qualcuno ne aveva già approfittato per stilare il certificato di morte artistica della band. Questo dunque è il momento della verità: se un primo scivolone può essere perdonato a chiunque, il secondo è spesso fatale. Una volta caduti, i cinque americani dovevano rialzarsi, senza indugio e senza possibilità di appello. Ci sono riusciti?
Uno dei più grossi limiti del detto album datato 2003 era probabilmente costituito dalla deludente prova di Labrie: linee vocali a lui poco confacenti unite a filtri esasperati e invadenti avevano minato la prestazione del singer canadese, rendendolo a tratti irriconoscibile. Qualche intempestivo detrattore ne aveva approfittato per definirlo “svociato”, “finito”. Sarebbe interessante sapere che cosa ne pensa oggi. Quella attuale si può infatti definire senza troppi indugi la miglior prestazione al microfono di Labrie dai tempi di Images & Words, forse addirittura la migliore della sua carriera. Eclettico, espressivo, ora suadente e melodico, ora agghiacciante e grintoso, a tratti teatrale e sempre disinvolto. In una parola, sorprendente: per chi non lo ama come per chi lo ha sempre difeso.
E gli altri? Inutile parlare dell’invidiabile perizia tecnica della quale tutti sono ormai da tempo a conoscenza: meglio invece esaminare direttamente le canzoni, ciò che di fatto va a costituire il vero valore di un album. Una nota di pianoforte per ripartire dove il treno dei pensieri ci aveva lasciato, e via libera alla fosca introduzione di The Root Of All Evil, terzo capitolo della trilogia inaugurata da The Glass Prison e proseguita con This Dying Soul. Un drumming bellicoso e infido copre le spalle a un riff massiccio e roccioso, ideale ponte di collegamento con il recente passato della band. Dunque ancora la stessa musica? Niente affatto. Il refrain infatti non si fa attendere, e in un attimo polverizza ogni dubbio: ci saranno molte sorprese. Suadente e melodico spezza di netto la tensione creata dalla strofa inquieta e stuzzica l’orecchio che per tutta la canzone continuerà a cercalo come ipnotizzato. Buona partenza.
Poco alla volta la musica si fa silenzio, rotto solo da un soffuso cinguettio e dai sordi rintocchi di una campana in lontananza. Come in Images & Words, subito una ballad… e che ballad! The Answer Lies Within, novella Hollow Years dal manto sinfonico, pare una mano invisibile allungata per accarezzare dolcemente la guancia dell’ascoltatore. Merito tra gli altri dell’eccellente Rudess al pianoforte, esaltato da un evocativo quartetto d’archi: irresistibile già del primo ascolto. Tastiere protagoniste anche in These Walls, e capaci di amalgamare con naturalezza sonorità classiche e futuristiche. Ottima l’intesa con le chitarre, fedeli compagne di staffetta sempre pronte ad attendere, sovrapporsi e fuggire da sole. Ne esce un brano cadenzato, onirico, ipnotico, quasi oppiaceo, un labirinto musicale con il solito Labrie a fare da compassato cicerone di melodie e umori tra un cambio di tempo e l’altro.
Ce n’è davvero per tutti i gusti. Che altro ci attende? Un ticchettio nervoso lascia intuire che per Portnoy e Myung il divertimento è appena iniziato. U2, ma anche le prime avvisaglie di Pink Floyd e Muse: eppure I Walk Beside You suona così dannatamente Dream Theater. C’è ritmo, melodia, feeling. E un’accoppiata già vincente nella traccia appena passata: bridge in crescendo su refrain compatto e avvolgente. Chiudete gli occhi e la vostra mente sarà rapita e portata in luoghi remoti dai quali non sarà facile distaccarsi.
Un attimo di silenzio per tornare al presente: sta arrivando qualcosa di grosso. Il basso di Myung bussa alla porta, ma non scomodatevi ad aprire: Panic Attack è un bolide che irrompe sfondando direttamente la parete. Stavolta il gagliardetto del main character è nelle mani di uno scatenato Petrucci, ma nessuno e dico nessuno si risparmia. Quasi cinquecento secondi che scorrono con la fluidità di un ruscello di montagna e con la potenza di un fiume in piena. Vi basti come assaggio quel che accade tra il terzo e il quinto minuto: maestoso break sinfonico tanto breve quanto incisivo, strofa irruente e minacciosa, bridge che distende e incanala la tensione prima di farla esplodere in un chorus spiritato che richiama alla mente i Muse di Hysteria, seguito a ruota dai soli al fulmicotone di un Petrucci ormai incontenibile e dell’onnipresente Rudess. Fa un po’ impressione sentire di tanto in tanto Portnoy martellare su tempi pari, sfoggiando un’inedita cattiveria in luogo delle consuete doti di acrobata, ma a quanto pare è capace anche di questo. Headbanging coi Dream Theater? Incredibile, ma possibile. Stranito finale elettronico in anticlimax dal quale nasce Never Enough, quello che di fatto considero l’episodio più debole dell’album. Non che si tratti di un brutto pezzo, anzi: una volta assuefatti il refrain convince vieppiù a ogni ascolto e Petrucci azzecca un altro assolo in tema. Tuttavia, sarà per i filtri applicati al peraltro ottimo cantato di Labrie che ora ricordano eccessivamente da vicino i soliti Muse (non è un mistero l’apprezzamento di Portnoy e soci per Absolution), sarà per le tastiere stavolta un po’ troppo cibernetiche, sarà che fin qui ci avevano abituato troppo bene, la morale è che questa volta tra le fauci rimane un retrogusto agrodolce.
Ma non c’è tempo per le lamentele: un’introduzione radiofonica sta già aprendo la via a Sacrificed Sons, capitolo interamente dedicato al tristemente noto attentato terroristico del 2001. Lasciatemelo dire, è in canzoni come la presente che si può toccare con mano la maturità artistica di una band di questo livello. Non una scontata ballad strappalacrime, non un patriottico inno alla futura rivincita, ma una suite riflessiva e intensa, un ripensamento consapevole – leggete le lyrics! – in cui “drammatico” non fa rima con “patetico”. Non è necessaria un’ascendenza di New York per provare un brivido durante il chorus, benché qui il vero centro focale si possa individuare nel lungo stacco strumentale di metà brano in cui i diversi strumenti, come emozioni in conflitto, lottano tra loro in un concitato certame senza vincitori né vinti.
Finita anche la suite, giunge il momento di tirare le somme… come? Ce n’è ancora? E’ vero, non abbiamo ancora parlato del piatto forte. La title track, quest’oggetto misterioso dal titolo enigmatico, troneggia minacciosa coi suoi ventiquattro minuti di lunghezza. Che cosa hanno ancora in serbo per noi questi cinque funamboli? Per dirla in breve, Octavarium – la canzone intendo – è come uno di quei colossali film dalla trama inestricabilmente complessa, di cui a una prima visione se ne capisce pressappoco la metà, ma che fin da subito lasciano spazio a un solo commento: “Geniale!”.
L’avete già ascoltata? No? Correte a farlo! A leggere oltre rischiate di rovinarvi la sorpresa. Ma se proprio volete conoscere la trama della pellicola prima di andarla a vedere, ecco dunque che cosa vi aspetta. Cinque diversi momenti, cinque capitoli di un’unica epopea in musica, l’ultimo tratto di circonferenza, quello che chiude il cerchio, o forse il primo ad aprirlo. Ma procediamo con ordine.
Attacco psichedelico di pinkfloydiana memoria, che con naturalezza va ad appoggiarsi su uno stacco acustico in cui Petrucci alla classica si accompagna inizialmente a una melliflua melodia di flauto (presto avrete modo di sentire tutta l’orchestra). Entra anche Labrie a condurre il docile arpeggio e cullare amorevolmente l’ascoltatore, fino a un crescendo improvviso e passionale che riscuote le membra intorpidite e avvia al nucleo dell’opera. Per un po’ i toni tornano pacati, mentre senza fretta si comincia a preparare il terreno per il decollo. Sono ancora una volta le tastiere a dettare il cambio di marcia, introducendo senza falsa modestia un imprevedibile excursus strumentale. Ma prima che possiate rendervene conto il cielo si è già fatto cupo: nubi nere e minacciose rendono inquiete le ritmiche proprio quando Labrie torna mattatore, coadiuvato dalle backing vocals del duo Petrucci-Portnoy chiaramente intenzionato a strafare. Ancora break strumentale: basso e chitarra si rincorrono in una fuga dalla quale escono vincitrici a sorpresa le tastiere, mentre cominciano a piovere inattesi arpeggi di chitarra classica, interrotti da una tempesta di lampi elettrici. Tutto è pronto per l’escalation finale. Un’inarrestabile, turbinante progressione che poco a poco vi penetrerà nelle viscere, salirà vorticando fino alla gola, ove finalmente deflagrerà nel quadruplice, apocalittico grido di un indemoniato Labrie: “Trapped inside this Octavarium!”. Da brividi, davvero, il suo screaming al vetriolo. Le vostre orecchie esiteranno a credere a se stesse, ma è tutto vero. Finita? Non ancora: come in tutte le grandi opere, l’epilogo non può che essere maestoso e immortale, e dunque ecco un finale orchestrale di ineguagliata intensità, insigne commiato che sublima la rinascita del Teatro dei Sogni.
Rinascita dunque. Rinascita a tutti gli effetti di una grande band che dimostra non solo di saper ancora una volta cambiare pelle senza rinnegare la propria essenza, scrollandosi di dosso con un sorriso il peso delle definizioni, ma anche di avere forza ed energia da vendere, tanto che le critiche del passato paiono già flebili e lontani fantasmi. Si è detto in precedenza della straordinaria prova di Labrie, si dice ora, se già non lo si era intuito, di quella non meno ispirata di Rudess. Versatile, eccentrico, folle, geniale, capace di passare dal classico al cibernetico in un battito di ciglia, con un nuovo gingillo (il continuum) ad arricchire il suo già ampio campo di competenze: ogni suo intervento è manna dal cielo per l’ascoltatore, con buona pace di chi non considera il suo stile adatto alla band. Si dirà anche di Myung, unico forse a non aver mai deluso neppure i fan più critici, chiaro e distinto come merita, ancora una volta fondamentale; nonché di Petrucci e Portnoy, citati in coppia perché accomunati da un grande merito: quello di non voler sempre e costantemente essere al centro dei riflettori, ma di saper anche accompagnare i compagni con paziente perizia, rinunciando a qualche balzo acrobatico in favore di una maggior concretezza. Ciò che si addice a due fuoriclasse di questo calibro.
Come sempre quando si parla di Dream Theater, non basta una manciata di ascolti per capire con che cosa abbiamo a che fare. Ogni canzone va letta e riletta attentamente, scrutata in ogni dettaglio, ispezionata in tutte le sfumature, prima di poter affermare di averne saggiato il valore: solo sulla lunga distanza si svela infatti il genuino valore di questa nuova opera magna. Affiancando le melodie più soavi ai riff più tirati, orchestrazioni raffinate a sonorità futuristiche, senza mai perdere la bussola o scadere nel banale, gli odierni re del progressive metal si riappropriano saldamente dello scettro del potere, che per un attimo era parso scivolar loro dalle mani.
Otto canzoni per l’ottavo album, otto gemme in otto note, con un incessante gioco di citazioni e riferimenti in bilico tra chiavi di lettura molteplici: quando un’ottava cade e si trasforma nell’infinito, termine e inizio finiscono fatalmente per coincidere, in un circolo virtuoso da cui pare impossibile uscire. Questo, signori, è Octavarium.
Tracklist:
1. The Root of All Evil (8.39)
2. The Answer Lies Within (5.19)
3. These Walls (7.36)
4. I Walk Beside You (4.29)
5. Panic Attack (8.13)
6. Never Enough (6.46)
7. Sacrificed Sons (10.43)
8. Octavarium (23.59)




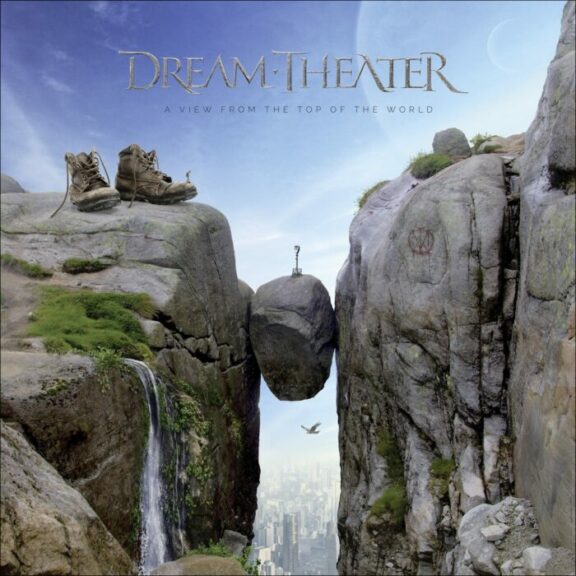
![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)


![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)
![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)